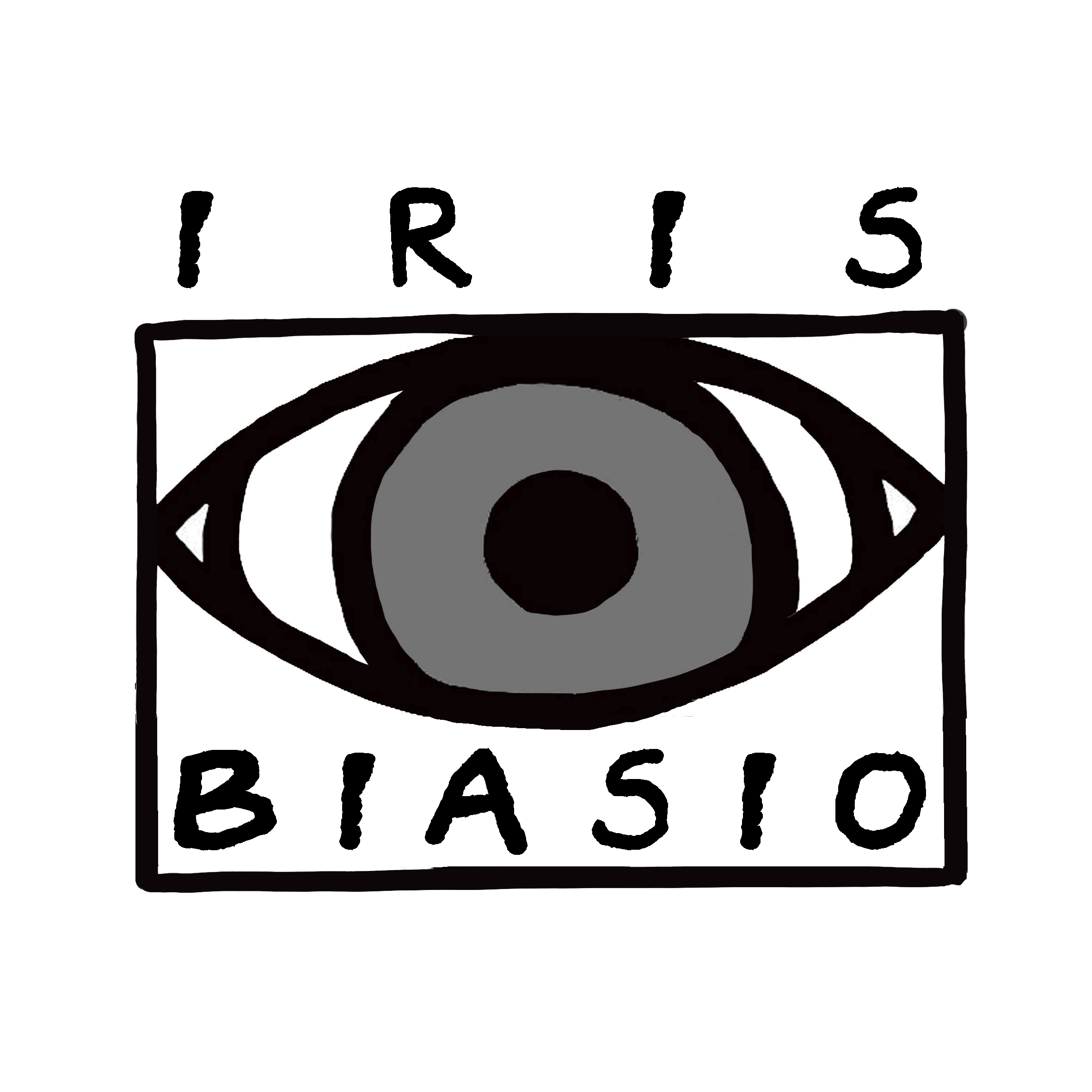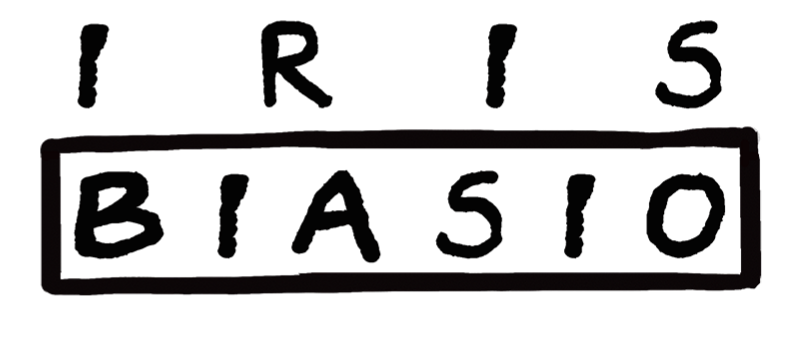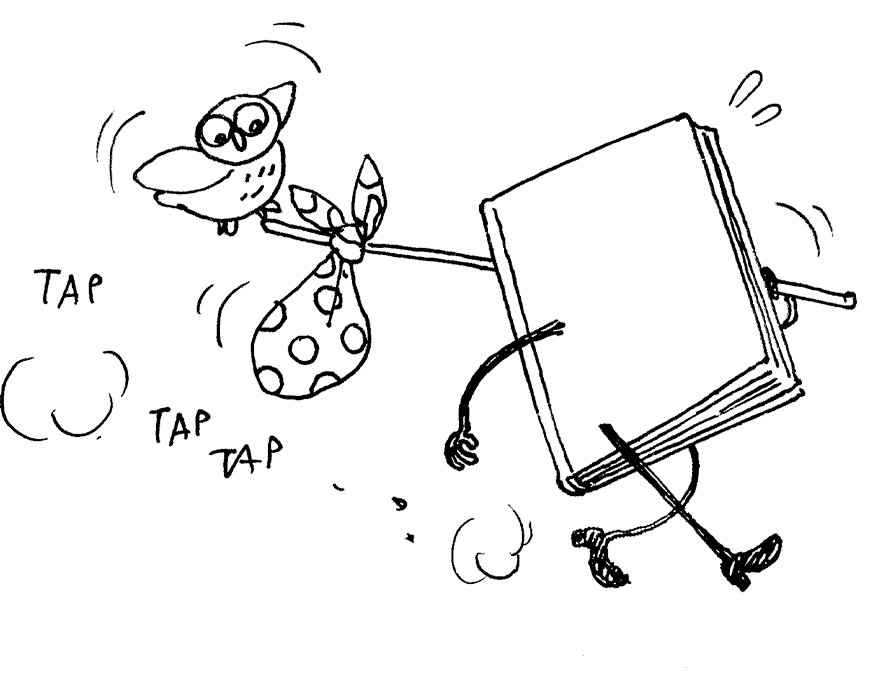Come riprendersi dopo che si è finito di fare un libro e cosa augurarsi per il suo nuovo viaggio.
Sono al primo vero articolo di questo blog e già mi trovo a sconvolgere il mio piano editoriale (per fortuna) perché sento veramente l’esigenza di parlarti di una cosa. Proprio in questi giorni ho finito una storia a fumetti, un vero librone, anni di lavoro che vedranno la luce a brevissimo e finalmente potranno andare liberi per il mondo.
E adesso?
Spoiler: non esistono delle vere soluzioni per riprendersi da questo. Provo sempre una sorta di odio/amore per la conclusione di un lavoro. Quando gli spazi occupati dal disegno e dalla scrittura ritornano ad essere liberi, la sensazione che ne deriva è molto bella, perché questo vuoto ritrovato rende disponibili a mettersi in movimento per riempirlo. D’altra parte, troppo ossigeno dopo tanto tempo lontani dall’aria aperta può far girare la testa. E così arrivano lo stordimento e la confusione, una specie di vera e propria nausea della ritrovata “libertà”.
Quanti i disegni che ho immaginato, quanti i disegni che non ho mai fatto e hanno portato il mio libro e me a essere quelli che siamo. Non è facile accogliere il momento in cui un libro cessa di appartenermi. Accade quando viene stampato, perché nel momento in cui si stampa, tutti i possibili tragitti che quel libro avrebbe potuto percorrere (e io con lui) vengono definitivamente scremati e definiti. Una volta stampato, il libro viene sigillato e in qualche modo si stacca da me. Potrò ritornarci più volte con i pensieri, potrò dedicargli qualche illustrazione o una riflessione, correggere e integrare dei dettagli per una nuova edizione, ma non potrò più trasformarlo. In un certo senso, il mio libro un po’ muore.
Tutti noi racchiudiamo molteplici contraddizioni e possibilità e così anche le storie che produciamo. Nel momento in cui si staccano da noi e arrivano agli altri, possono diventare dei veri e propri trampolini emotivi. Riflettendo sul meccanismo della lettura e implicitamente sulla natura delle storie, Proust ha scritto:
[…] credo che la lettura, nella sua essenza originale, [sia il] miracolo fecondo d’una comunicazione in seno alla solitudine[…]. Noi sentiamo benissimo che la nostra saggezza comincia là dove finisce quella dello scrittore […] Ma, per una legge singolare (e, d’altronde, provvidenziale) […] – legge che significa forse che la verità non possiamo riceverla da nessuno e che dobbiamo cercarla noi stessi -, quel che rappresenta il termine della loro saggezza ci appare soltanto come principio della nostra[…].1
Quanto bello è quando un libro, una storia, ci rispondono? Quando sentiamo, nonostante tutto, di non essere soli? Quando un lettore realizza “il miracolo della comunicazione”, crea un vero e proprio sistema di relazione: nonostante la solitudine, si confronta e si scontra con un’alterità che può mettere in moto le sue risorse più sorprendenti e autentiche. Accettando di lasciare andare una storia, ci si rende disponibili a vedere a che cosa darà origine nel mondo degli altri.
Sono d’accordo con Paul Auster quando dice che la scrittura non guarisce da nulla.2 Preferisco pensare che la scrittura di storie porti semplicemente verso altro, ossia ti permetta di trasformarti e di trasformare. La scrittura (che per me equivale a dire il disegno) è come una sorta di malattia. Si percepisce costantemente che qualcosa non va e lavorarci non basta mai. Non fraintendermi, non sto tessendo le lodi dello scrittore/artista dannato, si può scrivere in molti modi, ma nel mio caso il comune denominatore è sempre questo vuoto, un enorme punto di domanda verso cui mettersi in cammino e di cui rimanere costantemente meravigliati.
1. MARCEL PROUST, Sulla lettura, Rizzoli BUR, 2011 pp. 51-55 citato in MARYANNE WOLF, Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in un mondo digitale, Vita e pensiero, 2018, p.39.
2. PAUL AUSTER, Una menzogna quasi vera. Conversazioni con Gérard de Cortanze, Minimum Fax, 1998.